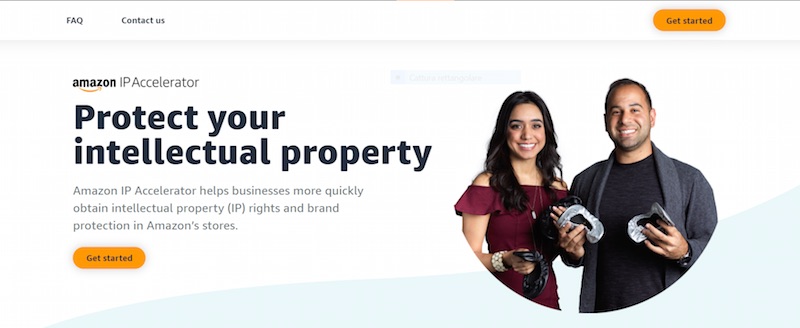L’emergenza sanitaria ha costretto le aziende a riorganizzare il lavoro, privilegiando lo smart working, e più in generale, le forme di lavoro a distanza. Il lavoro da remoto però è destinato a “durare” anche dopo la pandemia. Anche in Italia, infatti, in linea con quanto avviene nel resto d’Europa, negli ultimi 12 mesi c’è stato un forte aumento di offerte di lavoro da remoto. A sostenerlo è Indeed, il portale per chi cerca e offre lavoro in tutto il mondo. I dati sugli annunci di lavoro pubblicati sulla piattaforma offrono infatti una visione a largo spettro su come la pandemia all’inizio del 2021 abbia rimodellato il mercato del lavoro, evidenziando tendenze che suggeriscono cambiamenti più profondi e destinati a durare.
Un’impostazione sempre più flessibile e da remoto
L’emergenza sanitaria ha contribuito a dare al lavoro un’impostazione sempre più flessibile e da remoto, offrendo la possibilità di svolgerlo da luoghi diversi. In Italia, da febbraio 2020 a febbraio 2021 gli annunci di lavoro in modalità smart sono cresciuti del 296% rispetto al totale, rappresentando ora il 6,4% degli annunci pubblicati sul sito italiano di Indeed (in aumento rispetto all’1,6% del febbraio 2020).
Milano guida la classifica dell’offerta di lavoro da remoto
L’offerta di lavoro da remoto è più rilevante nelle grandi città, in linea con quanto accade nel resto in Europa. Milano guida la classifica, con una quota del 10,4%, non distante Roma, con il 9,8%, mentre le percentuali nel resto dell’Italia sono più contenute, con il 5,5%. L’andamento dei job post trova conferma anche nella ricerca internazionale commissionata da Indeed per indagare lo stato d’animo di lavoratori e datori di lavoro. In Italia, un datore di lavoro su 2 ha dichiarato di aver introdotto la possibilità di lavorare da casa poiché al tempo del Covid risulta irrinunciabile per le persone. Chi cerca lavoro è infatti alla ricerca di professioni che possano essere svolte con flessibilità e da remoto. Tanto che negli ultimi 12 mesi sul sito italiano di Indeed, riporta Adnkronos, queste ricerche sono cresciute del +347%.
Una tendenza che riguarda anche il processo di selezione
“Le evidenze indicano che il lavoro a distanza sta diventando una modalità sempre più radicata, anche se è nelle città che si nota una maggiore offerta, per via della tipologia di lavori tipicamente ospitati nelle aree urbane – afferma Dario D’Odorico, responsabile per il mercato Italia di Indeed.co. -. Quello che è certo è che i numeri di chi cerca lavoro da remoto non sembrano diminuire, il che significa che il lavoro a distanza rimarrà una tendenza ampiamente diffusa, e molte aziende dovranno adottare un approccio flessibile per competere anche in fase di recruiting. Una apertura – sottolinea D’Odorico – che riguarda non solo possibilità di svolgere le proprie mansioni da remoto, ma anche tutto il processo di selezione”.